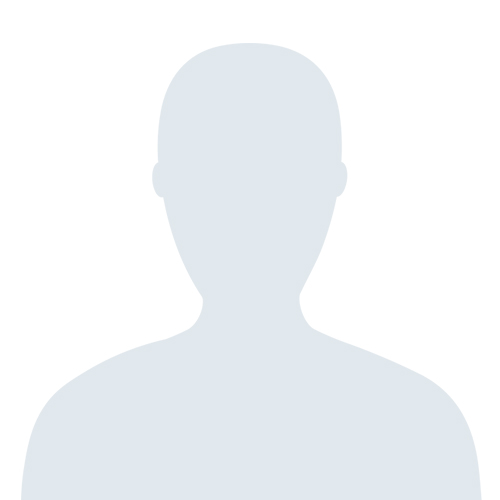La vicenda del filmato che riprende maltrattamenti contro un ragazzo disabile in una classe dell’istituto Steiner di Torino e quindi uploadato su Google Video ha dato origine a tre diverse inchieste in tre diverse Procure: la Procura di Roma, quella di Torino e quella di Milano. Le prime due stanno indagando contro i protagonisti del video per violenza privata ai danni del ragazzo disabile. La Procura di Milano, invece, oltre ai ragazzi dello Steiner, ha iscritto nel registro degli indagati due rappresentanti di Google Italia, a seguito di una querela presentata dal legale dell’associazione Vividown per il reato di concorso in diffamazione aggravata ai danni dell’associazione stessa.
La diffamazione nel video incriminato
Una prima domanda è quale parte del video sia da Vividown ritenuta diffamante nei suoi confronti. Il reato di diffamazione ha per oggetto l’offesa della reputazione di un soggetto assente e la “vittima” del reato può essere una persona giuridica o una associazione – come nel caso di Vividown. È un reato a “dolo generico”, ovvero è sufficiente che la persona che commette il reato sia consapevole di usare espressioni che offendono l’altrui onore o reputazione. Nel video incriminato (attualmente rimosso e non più visibile), secondo la ricostruzione di Repubblica che probabilmente riprende quella del blog “Giornalettismo”, i ruoli dei ragazzi sono precisi: «Il primo ragazzo ha fatto il gesto di percuotere il compagno, il secondo ha tracciato simboli nazisti sulla lavagna e si è prodotto in un saluto romano, il terzo ha ripreso la scena con una piccola videocamera; una studentessa, infine, nell’agosto successivo ha diffuso una copia del filmato su internet». A un certo punto del filmato, uno dei ragazzi, indicando il compagno affetto da una grave forma di autismo, avrebbe finto di telefonare proprio all’associazione Vividown. Ferruccio Sansa su Repubblica racconta quali sarebbero state le parole pronunciate: «Salve, siamo di Vividown, un nostro mongolo si è cag… addosso e mo’ non sappiamo che fare perché l’odore ci è entrato nelle narici». La querela contro i protagonisti del video innanzitutto e contro Google per “concorso” in diffamazione aggravata parte tutta da qui.
Non essendo stato diffuso l’originale della querela, dobbiamo giocoforza partire dalle ricostruzioni delle testate giornalistiche – che, come vedremo, non in tutto coincidono. Per tutti (si veda Repubblica e il Corriere come esempio) l’ipotesi di diffamazione contestata è “aggravata”. Ma di quale aggravante si tratta? Qui le ipotesi divergono, come nota anche Carlo Felice Dalla Pasqua nella sua ricostruzione. C’è chi scrive (o fa intendere) di diffamazione a mezzo stampa, e chi invece scrive (o fa intendere) di un generico obbligo a impedire i reati, applicabile a Google in quanto fornitore di servizi su Internet.
La diffamazione aggravata è a mezzo stampa?
La possibilità che il reato contestato a Google sia di concorso in diffamazione con l’aggravante del mezzo stampa (terzo comma dell’articolo 595 c.p.) è stata evocata da molti interventi sul tema ed è quella che inevitabilmente desta maggiore preoccupazione. Proprio Repubblica (seguito poi da altri) sembra sostenere questa ipotesi, e scrive che il reato di cui Google è accusata «ricalca la normativa riguardante l’omesso controllo da parte dei direttori di testate giornalistiche sui contenuti pubblicati. E questo, sulla base di una sentenza del Tribunale di Aosta del 2006 ha equiparato la figura del titolare di un blog a quella del direttore di un giornale». Il tribunale di Aosta, nella sentenza citata da Repubblica, ha fatto una analogia in malam partem (ovvero sfavorevole al reo), equiparando la figura di un titolare di un blog a quella di un direttore di una testata giornalistica – semplicemente perché può controllare i commenti così come il direttore può controllare gli articoli pubblicati. La stessa analogia vale anche per Google, e anche nel caso di un video caricato su Google Video? Google Video è davvero equiparabile a un direttore di una testata giornalistica che non ha controllato l’articolo di un suo redattore? Difficile. Innanzitutto perché il divieto di analogia non lo consente. Ma se pure vi fosse analogia con la stampa (come nel caso della discutibile sentenza di Aosta appena citata), sono due le responsabilità per il “non controllo” da parte di un direttore responsabile: o per omissione di controllo (negligenza, non ho proprio letto), o per concorso (ovvero non ho controllato proprio per consentire la diffusione di un dato contenuto).
Diffamazione a mezzo stampa: o negligenza o concorso
La differenza non è solo questione di lana caprina. Infatti nel primo caso (l’omissione per negligenza) Google non sarebbe imputabile di “concorso” con gli autori del video in diffamazione aggravata: l’omissione è un reato autonomo a sé stante. Rimane il secondo caso – la “volontà” di non controllare, di “non” impedire o comunque di agevolare la pubblicazione del contenuto. Volontà che potrebbe portare al reato di concorso in diffamazione aggravata, ma andrebbe innanzitutto dimostrato che Google è equiparabile ad un direttore di una testata giornalistica, e, in secondo luogo, che Google abbia “voluto” non controllare.
Sgombrato un po’ il campo dall’equivoco del mezzo stampa, c’è però un’altra possibile aggravante prevista dalla normativa sulla diffamazione. Sempre l’articolo 595 prevede la possibilità che il reato di diffamazione sia aggravato anche da “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. Poche ore dopo l’individuazione da parte delle autorità inquirenti degli autori del video, l’associazione Vividown dichiara che «chi rende disponibili immagini su Internet deve essere in grado di controllarne il contenuto». Il riferimento, più che al mezzo stampa, pare essere in generale ai fornitori di servizi alla società dell’informazione – ovvero i “provider”. Ciò sembra trovare conforto dalla ricostruzione del contenuto della querela operata da alcuni lanci dell’agenzia Ansa e dal Corriere della Sera, che parlano genericamente di “mancato controllo sui contenuti” senza riferirsi alle disposizioni in materia di stampa.
Google e l’obbligo di sorveglianza
La questione dunque si sposta dalla stampa a Internet. È possibile imputare a Google in quanto erogatore di servizi il concorso in diffamazione aggravata – come da querela di Vividown? Come in molti hanno notato (si veda per esempio l’interessante dossier di Punto Informatico, l’opinione di Daniele Minotti, e il già citato Carlo Felice Dalla Pasqua), la normativa di riferimento in materia di servizi erogati via Internet è il decreto legislativo n. 70 del 2003. L’articolo 17 del decreto sancisce l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza del prestatore di servizi della società dell’informazione sulle informazioni che trasmette o memorizza. Che non ha – aggiunge l’articolo – alcun obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Non vi è, in altre parole, nél’obbligo di sorveglianza, né quello di fare lo “sceriffo” cercando eventuali colpevoli. Anche in questo caso, insomma, è necessario dimostrare che Google abbia “voluto” quel video sui suoi server – e non semplicemente che non se ne sia accorto. Esiste però qualche altra residua responsabilità ipotizzabile per Google Italia in quanto “provider”. L’articolo 16 del decreto citato afferma che non esiste alcuna responsabilità in due casi: se il “provider” non sa, oppure se si attiva prontamente a rimuovere i contenuti contestati dalle autorità competenti.
Google sapeva?
Il primo caso è appunto se il “provider” ha o non ha conoscenza effettiva dell’illiceità manifesta del contenuto ospitato sui suoi server. La diffamazione a Vividown – così come ci è stata raccontata facendo riferimento alle frasi pronunciate dal ragazzo nel video – era dotata di “illiceità manifesta”? Non è detto – al contrario degli atti di bullismo che però non paiono essere direttamente contestati al motore di ricerca. Il punto è comunque se, in relazione al funzionamento del servizio di video sharing, vi siano elementi in grado di dimostrare che Google fosse effettivamente a conoscenza dell’esistenza del video e del suo contenuto diffamatorio o, comunque, illecito. Che Google sapesse, insomma.
Google Video offre la possibilità ai soli utenti che hanno un account Google di usufruire del servizio di video sharing – quindi di caricare propri filmati in Rete. Al contrario, chiunque può visionare i video caricati e, soprattutto, segnalare la presenza su Google Video di un “contenuto non adatto”. Può farlo sia attraverso una form breve, che si trova alla destra del video, o attraverso una più estesa procedura di segnalazione. In entrambi i form c’è la possibilità di indicare le specifiche violazioni, ovvero nel dettaglio «contenuto illegale; violazione della privacy personale; oscenità o pornografia; odio o incitamento alla violenza; scene o atti di violenza che producono lesioni gravi o morte». Facile notare che il bullismo, inteso come scene o atti di violenza in assenza di lesioni gravi, non è previsto. Ma che valore giuridico possono avere queste segnalazioni? Quale dovrebbe essere il criterio che porta alla rimozione di un video dietro segnalazione? Come si fa, in assenza dei poteri di indagine delle autorità, ad essere sicuri dell’illiceità di un contenuto? È, in ogni modo, controverso se l’esistenza di un form per i reclami possa portare automaticamente a ritenere Google, o i prestatori di servizi della società dell’informazione in genere, consapevole dell’illiceità di un contenuto – a prescindere da un diretto esame.
Il secondo caso – in cui non esiste responsabilità di un fornitore di servizi internet – è se il provider, a richiesta delle autorità competenti, si attiva prontamente per rimuovere il contenuto illecito. Gli autori del blog Giornalettismo (come si apprende dall’intervista del legale rappresentante di Vividown rilasciata al Corriere della Sera il 12 novembre) avrebbero telefonato all’associazione per segnalare la presenza del filmato su Google Video. L’associazione avrebbe quindi contattato telefonicamente la senatrice Emanuela Baio, che si è rivolta alla Polizia Postale. Dopo poche ore dalla denuncia il video non era più accessibile. Il tutto si è risolto, come conferma lo stesso Giornalettismo, dopo soli 2 giorni dal primo post in cui ne veniva denunciata la presenza in Rete. Non sembra, quindi, che il comportamento di Google sia censurabile sotto il profilo della collaborazione con le attività competenti – come peraltro hanno più volte dichiarato alla stampa i responsabili di Google Italia.
L’onere della prova
Per dimostrare il concorso in diffamazione aggravata di Google nel caso del video di bullismo – sia che si applichi l’aggravante a mezzo stampa (difficile), sia le regole sui fornitori di servizio su Internet (più probabile) – Vividown dovrà dimostrare innanzitutto che Google era consapevole della presenza di quel video sui suoi server, quindi che era consapevole della sua potenziale offensività, infine che abbia “voluto” agevolare dolosamente la diffusione dei contenuti illeciti. Tutte dimostrazioni assai complicate – come è facile dedurre. Sempre che, ovviamente, la diffamazione in sé (le frasi pronunciate dai ragazzi) sussista.