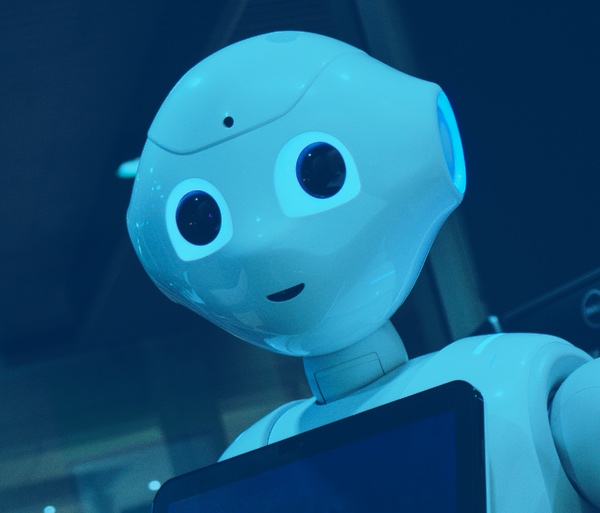- Come la rete stimola la nostra disattenzione
- Perché rischiamo che la AI ci renda la vita troppo comoda
- Perché nutriamo troppa fiducia in quello che sappiamo e crediamo
- Come riprenderci la curiosità
- Quali opportunità abbiamo per restare umani ed elevarci
1. Come la rete stimola la nostra disattenzione
Anche se è troppo presto per osservare qualche effetto significativo della tecnologia sul nostro cervello, è plausibile che si diano effetti di lungo termine. Come ha notato Nicholas Carr, che scrive dell’intersezione fra tecnologia e cultura, nel suo Internet ci rende stupidi? Come la Rete sta cambiando il nostro cervello, l’esposizione ripetuta ai media online comporta un cambiamento cognitivo, dall’elaborazione intellettuale profonda (come la riflessione concentrata e critica) a processi veloci condotti con il pilota automatico, come leggere per sommi capi ed esplorare rapidamente, spostando l’attività neurale dall’ippocampo (l’area del cervello coinvolta nel pensiero profondo) verso la corteccia prefrontale (la parte del cervello coinvolta nelle transazioni rapide, subconsce).
In altre parole, cediamo accuratezza in cambio di velocità e diamo la priorità alle decisioni impulsive rispetto al giudizio deliberato. Per usare le parole di Carr,
Internet è un sistema di interruzione. Conquista la nostra attenzione solo per strapazzarla”.
Qualche risultato degli studi scientifici, per quanto preliminare, fa pensare che certi influssi prodotti sul cervello dalla tecnologia possano essere visti (e misurati), per esempio variazioni nella materia bianca nei bambini in età prescolare, come conseguenza di un uso estensivo degli schermi. Si stima che il 62 percento degli studenti ora usi i social media durante le ore di lezione e fino al 50 percento delle distrazioni in aula sono state attribuite ai social media.
Gli studenti universitari passano dalle otto alle dieci ore al giorno sui siti di social media e, come si poteva immaginare, il tempo trascorso online è correlato inversamente con le prestazioni accademiche. Non sorprende poi che regolarmente i dati ottenuti dalle ricerche colleghino livelli più elevati di uso di Facebook con livelli più elevati di distrazione accademica, che a loro volta abbassano i risultati accademici.
Notifiche, messaggi, post, like e altri feedback gratificanti sequestrano la nostra attenzione e creano uno stato costante di iper-vigilanza, interruzione e distrazione, in grado di produrre livelli significativi di ansia, stress e sintomi da astinenza.
Questo è particolarmente problematico nei giovani, che sono in una fase di sviluppo intellettuale e dell’identità e dipendono dai segnali di validazione e feedback che arrivano dagli altri. Inoltre, quando la nostra attenzione è catturata da distrazioni causate dall’AI, tendiamo ad affidarci maggiormente a processi decisionali intuitivi o euristici, facilmente preda di distorsioni, stereotipi e pregiudizi, tutte cose che rendono i giovani (e anche quelli che giovani non sono più) di mentalità ristretta e meno inclusiva.
Per avere una mente aperta, bisogna essere disposti a cercare attivamente informazioni che contraddicono i nostri stessi atteggiamenti, il che è molto più difficile (e meno probabile) quando non si presta attenzione e si è preda degli algoritmi dell’AI.
Leggi anche: Una AI che cambia il nostro modo di pensare
Risultati scientifici convincenti indicano che distrarre i giovani dai social media tende a indurre stress, come tenere lontani i fumatori o i bevitori dalle sostanze da cui sono dipendenti.
In effetti, minori livelli di controllo dell’attenzione sono stati associati a livelli più elevati di ansia, e l’ampia varietà di distrazioni digitali fornite dall’era dell’AI sono una minaccia per il nostro controllo dell’attenzione, perché la monopolizzano. Quanto più si è vulnerabili a deficit del controllo dell’attenzione, tanto più le capacità di apprendimento saranno compromesse dalle distrazioni digitali. Perciò, nelle persone che già per natura sono inclini alla disattenzione perché hanno un potenziale più ridotto di controllo dell’attenzione, l’uso dei social media causa livelli significativamente superiori di stress psicologico.
L’essere digitalmente dipendenti compromette anche la salute e il benessere fisico. Già durante le prime fasi di sviluppo dell’AI e dei social media, i risultati degli studi accademici indicavano una forte correlazione fra uso degli schermi e indice di massa corporea, e il comportamento sedentario è aumentato perché negli ultimi anni l’attività fisica è diminuita, parallelamente alla diffusione delle tecnologie di Internet.
David Meyer, uno dei maggiori studiosi del multitasking, mette a confronto i danni dell’era dell’AI con quelli dei giorni gloriosi dell’industria del tabacco:
Le persone non sono consapevoli di quello che accade ai loro processi mentali, esattamente come anni fa non potevano guardare nei loro polmoni e vedere i depositi residui.
L’affermazione potrà essere anche un po’ esagerata, ma è chiaro che i nostri tipici schemi di attenzione sono cambiati drasticamente nell’arco degli ultimi quindici anni solamente. Per usare le parole di Linda Stone, viviamo in un’epoca di attenzione parziale continua.
Sarebbe bello avere una soluzione semplice per questi problemi, ma non esiste. La tecnofobia potrebbe sembrare un’opzione allettante, ma ha un costo sociale ed economico elevato, poiché ci trasforma in cittadini inutili e improduttivi nell’era dell’AI, dove raramente i luddisti sono accettati o integrati. Essere offline equivale ad avere un’esistenza totalmente ignorata, come l’albero secolare che crolla nella foresta quando non c’è nessuno a sentire il rumore dello schianto. Bloccare le app o limitare l’accesso a Internet è un ovvio compromesso intermedio, dato che ci consente di evitare almeno alcune distrazioni digitali
Quando John Coltrane, leggenda del jazz, attraversava una fase di attaccamento compulsivo al suo sassofono e si lamentava con Miles Davis, altro componente del gruppo, di non riuscire a smettere di suonare il suo strumento, Miles gli rispose: Hai provato a toglierti dalla bocca quella dannata cosa?. Potremmo applicare la stessa logica per controllare le nostre distrazioni digitali più ricorrenti. Per esempio, ho scoperto che un modo utile per evitare di essere distratti da Facebook è cancellare completamente l’app. Chi ci avrebbe mai pensato? Certo, ci sono momenti in cui mi manca il sentimento nostalgico di curiosare quello che fanno i miei vecchi amici delle scuole superiori o di controllare che cosa mangiano a colazione gli estranei o di vedere se un mio lontano cugino è arrivato in albergo, ma in qualche modo sospetto che non sia una perdita terribile per la nostra civiltà.
2. Perché rischiamo che la AI ci renda la vita troppo comoda
Quando gli algoritmi trattano o elaborano proprio i dati che utilizziamo per prendere decisioni e fare scelte di vita pratiche e significative, l’AI non si limita a prevedere il nostro comportamento, ma lo influenza anche, modificando il modo in cui agiamo.
Alcuni dei cambiamenti guidati dai dati che l’AI impone alla nostra vita possono sembrare banali, come quando acquistiamo un libro che non leggeremo mai o ci abboniamo a un canale televisivo che non guarderemo mai, mentre altri possono cambiarci la vita, come quando trasciniamo il dito verso destra per approvare quello che diventerà il nostro futuro marito o quella che diventerà la nostra futura moglie. La maggior parte di noi sa di matrimoni che sono iniziati (o finiti) con Tinder, e i risultati delle ricerche indicano che si formano più relazioni di lungo termine attraverso gli appuntamenti online che con qualsiasi altro mezzo.
In modo simile, quando utilizziamo Waze per scoprire come andare da A a B, controlliamo l’app delle previsioni del tempo prima di scegliere che cosa indossare, o usiamo Vivino per vedere la valutazione data a un vino dagli utenti, chiediamo all’AI di farci da concierge di vita, senza dover pensare troppo e al contempo cercando di aumentare la soddisfazione per le nostre scelte.
In questo modo, l’AI ci esime dalla sofferenza mentale causata dall’eccesso di scelte, quello che i ricercatori chiamano il paradosso della scelta. Quando il ventaglio delle scelte cresce, aumenta anche l’incapacità di scegliere o di essere soddisfatti delle proprie scelte, e l’AI è in gran parte un tentativo di minimizzare le complessità effettuando le scelte per noi. Scott Galloway, docente alla New York University e autore di Post Corona, ha notato che quello che vogliono realmente i consumatori non è una scelta più ampia, bensì la fiducia nelle proprie scelte. Quante più scelte avremo, invece, tanto meno avremo logicamente fiducia nella nostra capacità di compiere la scelta giusta. Sembra che Henry Ford adottasse una forma forte di attenzione per il cliente, quando pronunciò la famosa frase:
I clienti sono liberi di scegliere qualsiasi colore per la loro auto, purché sia il nero”.
Indipendentemente da come evolverà, probabilmente l’AI continuerà a rendere meno faticose le nostre scelte. Non è affatto peregrina l’idea di un futuro in cui chiederemo a Google che cosa studiare, dove lavorare, o chi dovremmo sposare. Inutile dire che gli esseri umani non possono vantare una storia particolarmente brillante in queste scelte, non ultimo perché le abbiamo sempre affrontate in modo casuale e impulsivo. Così, come in altre aree del comportamento che diventano obiettivo dell’automazione dell’AI (per esempio, i veicoli a guida autonoma, i bot per i colloqui di lavoro in video e le decisioni delle giurie), l’asticella è collocata molto in basso. L’AI non deve essere molto precisa, e meno che mai perfetta, per fornire valore rispetto ai comportamenti umani medi o tipici. Nel caso delle auto a guida autonoma, questo semplicemente significherebbe ridurre il numero dei morti a causa di incidenti (sono 1,35 milioni ogni anno). Nel caso dei bot per i colloqui in video, l’obiettivo sarebbe spiegare più del 9 percento di variabilità nelle future performance lavorative rispetto a quello che spiegano i colloqui di lavoro tradizionali (correlazione dello 0,3 nel migliore dei casi). Nel caso delle decisioni delle giurie, basterebbe ridurre l’attuale probabilità che le giurie condannino ingiustamente una persona innocente, che è del 25 percento (cioè tre condannati su dieci sono in realtà innocenti).
Quindi, anziché preoccuparci dei benefici che potrebbe darci l’AI, occupandosi effettivamente di decisioni che storicamente erano basate esclusivamente sul nostro pensiero, dovremmo forse chiedere che cosa facciamo esattamente del tempo che l’AI libera per la nostra riflessione. Se l’AI ci risparmia decisioni noiose, banali, ma addirittura difficili, che cosa facciamo di tutta l’energia mentale che così si libera? Questa, in fin dei conti, è sempre stata la promessa e la speranza di ogni rivoluzione tecnologica: standardizzare, automatizzare e scaricare compiti sulle macchine, in modo da poterci dedicare ad attività intellettuali o creative di livello più alto.
Storicamente, abbiamo sempre agito in base al presupposto che gli esseri umani fossero creature psicologicamente complesse e piuttosto profonde, ed è il motivo per cui ci voleva del tempo per imparare davvero a conoscere qualcuno. Supponiamo di volere aiutare un altro essere umano a capire chi siamo: è un compito monumentale, forse addirittura impossibile. Chi siamo potrebbe articolarsi nella somma di tutti i nostri comportamenti (cose difficili da tracciare, registrare, osservare e interpretare, anche nell’attuale età del capitalismo della sorveglianza), più la somma di tutti i nostri pensieri e sentimenti, un’area decisamente ancora più torbida. Inoltre, pensiamo a tutti i livelli di spiegazione necessari per dare un senso a ogni nostro aspetto, dai processi biologici (per esempio, la nostra peculiare costituzione fisiologica, biologica, genetica e così via), fino alle teorie sociali, psicologiche, culturali e filosofiche che mirano a tradurre i nostri personali schemi di attività in un modello dotato di senso di noi stessi.
All’estremo inferiore dello spettro della complessità si trova l’approccio dell’AI alla nostra definizione: semplifica sostanzialmente il compito e affronta la questione in modo molto superficiale, generico, cioè semplicemente limita l’insieme delle cose che facciamo, sentiamo e pensiamo, limitando il repertorio potenziale dei comportamenti che potremmo mostrare in una giornata qualsiasi, o nel corso della vita, per migliorare qualsiasi modello mentale altri abbiano di noi. In altre parole, anziché semplificare eccessivamente il modello, possiamo tentare di semplificare noi stessi.
Ci sono persone così facili da leggere, che bastano una o due categorie per comprenderle e prevedere i loro comportamenti, nel senso che sono emblematiche delle loro categorie rilevanti. Alcune riescono a combinare interessi in concorrenza, atteggiamenti antagonistici e schemi di comportamento quasi paradossali; possiamo definirle persone imprevedibili. Se vogliamo aiutare gli altri a capire chi siamo, che cosa siamo, o che cosa è probabile che facciamo, cerchiamo semplicemente di eliminare dalla nostra vita ogni complessità e ogni imprevedibilità. Riduciamo la nostra vita all’ovvio, al monotono e al ripetitivo, e il modello che abbiamo di noi crescerà rapidamente in potenza predittiva, non importa quanto sia semplice. Per esempio, se il nostro modello di noi è quello di un essere umano che passerà le giornate a guardare vari schermi e a fare clic, tap e scorrere pagine diverse in modo sempre più ripetitivo, perfino un computer sarà in grado di capire chi siamo. Agire come robot ci rende più familiari ai robot, e noi stiamo ottimizzando la nostra vita a questo scopo.
3. Perché nutriamo troppa fiducia in quello che sappiamo e crediamo
Tutti crediamo a quello in cui vogliamo credere. Perché? Perché le nostre illusioni sono consolanti. Ci aiutano a sostituire una versione spiacevole della realtà con una che invece è rassicurante e compatibile con il modo indulgente e tollerante in cui vediamo noi stessi.
Per combattere le nostre stesse autoillusioni, dobbiamo avere meno fiducia nelle nostre idee, opinioni e conoscenze. Fare domande è più importante che ottenere risposte. Per riprendere una famosa osservazione di Stephen Hawking,
Il peggior nemico della conoscenza non è l’ignoranza, ma l’illusione della conoscenza.
Dobbiamo essere disposti ad accettare feedback dagli altri, che colmano la lacuna fra come noi ci vediamo e come ci vedono gli altri. Ma è un compito impegnativo, perché l’era dell’AI ha annacquato i feedback facendoli diventare un rituale senza senso, ripetitivo e semiautomatico che produce solo circuiti di retroazione positiva. Così, per esempio, quando pubblichiamo qualcosa su Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter o Instagram, non è difficile ottenere qualche mi piace, perché mettere un like richiede relativamente poca energia e ha un costo molto basso. La maggior parte delle persone metterà il mi piace, anche se il feedback è fasullo, ed è probabile che venga ricambiato in futuro. Quando LinkedIn era agli inizi, c’erano persone che raccoglievano lunghe raccomandazioni da altri, che poi ricambiavano, perciò quelle raccomandazioni raccontavano qualcosa degli amici più che delle competenze o dei talenti delle persone. Questo però rende il feedback di gran lunga meno utile di quello che dovrebbe essere. C’è voluto più di un decennio perché Facebook finalmente decidesse di includere un pulsante non mi piace, anche se Mark Zuckerberg lo ha descritto come una funzione per esprimere empatia.
Siamo incentivati a ignorare i pochi feedback critici o onesti che potremmo realmente ricevere. Pensiamo al ruolo in cui dare un aiuto agli altri con feedback costruttivi conta di più, cioè quello di leadership. Dai risultati delle ricerche emerge che i manager trovano estremamente difficile dare ai dipendenti feedback negativi sulle loro performance, ed è il motivo per cui spesso le persone rimangono sorprese quando non ottengono una promozione o un premio, e perfino quando vengono licenziate.
D’altra parte, manager e leader sono predisposti a ignorare i feedback negativi, perché non sono critici verso se stessi e preferiscono circondarsi di persone che lecchino loro i piedi. Quanto più sei inadeguato come leader, tanto più puoi aspettarti che le persone ti lecchino i piedi.
La capacità di presentarci in modi strategicamente e politicamente astuti è determinante per il successo in qualsiasi contesto professionale. Quelli che vivono seguendo il principio non preoccuparti troppo di quello che gli altri pensano di te raramente sono visti in modo positivo dagli altri. Dalle ricerche accademiche emerge che le persone di successo si preoccupano molto della propria reputazione e che stanno molto attente a presentarsi in un modo socialmente attraente.
Quando abbiamo il lusso di incontrare fisicamente colleghi e clienti, gli altri possono formarsi un’impressione di noi in base alla nostra presenza fisica in uno spazio tridimensionale, al modo in cui stringiamo le mani e alla nostra voce, il che, come spiega Erica Dhawan nel suo Digital Body Language, viene ampiamente riprodotto anche nei contesti virtuali.
Il problema è che l’alternativa non è molto divertente. Essere i critici più severi di noi stessi, giudicare le nostre azioni da un punto di vista esigente e perfezionista è l’esatto opposto di quello che chiunque farebbe, se è anche vagamente interessato a godersi la vita.
Anche se è un fattore necessario per lo sviluppo personale efficace, l’autoconsapevolezza non basta. È perfettamente possibile che qualcuno sia consapevole di sé e raggiunga un livello profondo di comprensione di sé, eppure non migliori.
4. Come riprenderci la curiosità
Il fatto che la curiosità stia diventando più rara nell’era dell’AI spiega perché sia tanto ricercata. In effetti, la curiosità è esaltata come una delle competenze più cruciali per l’ambiente di lavoro moderno, e i risultati delle ricerche scientifiche dicono che non è solo un predittore significativo della occupabilità di una persona (cioè della sua possibilità di ottenere e conservare un posto di lavoro attraente). Le nazioni in cui le persone hanno un livello di curiosità più elevato godono anche di una maggiore libertà economica e politica e possono vantare anche un Pil più elevato.
I posti di lavoro futuri diventano meno prevedibili, e un maggior numero di organizzazioni, perciò, assumerà le persone sulla base di quello che potrebbero apprendere, e non di quello che già sanno. Ovviamente, la carriera di una persona dipenderà ancora in gran parte dai suoi risultati accademici che sono (ancora) influenzati dalla sua curiosità. Dato che non si può apprendere alcuna competenza senza un livello minimo di interesse, la curiosità può essere considerata uno dei fondamenti determinanti del talento. Una frase famosa di Albert Einstein:
Non ho particolari talenti, sono soltanto appassionatamente curioso.
A un incontro del World Economic Forum a Davos, il ManpowerGroup ha previsto che la learnability sarebbe stata un antidoto fondamentale all’automazione. Chi è più disposto e più in grado di migliorare le proprie competenze e di svilupparne di nuove è meno probabile che venga sostituito dall’automazione. Quanto più ampio è il raggio delle competenze e delle abilità che acquisite, tanto più rilevanti rimarremo nell’ambiente di lavoro. Viceversa, se ci concentriamo sull’ottimizzazione delle nostre performance, il nostro lavoro finirà per consistere di azioni ripetitive e standardizzate che una macchina potrebbe eseguire meglio.
Alcuni dei cambiamenti indotti dall’AI possono migliorarci, altri invece possono deumanizzarci. Un libro che ci spiega come stia a noi decidere se e come succederà.
Essere curiosi o di mente aperta: è più facile a dirsi che a farsi. Nella psicologia, sono stati molti storicamente gli studi sull’apertura mentale, di solito sotto la voce apertura all’esperienza. Forse perché i dati sono dovuti soprattutto a studenti di psicologia negli Stati Uniti, che in genere sono liberali quanto gli accademici che conducono queste ricerche, l’apertura mentale è stata più o meno definita come l’essere politicamente liberali o, diciamo così, democratici anziché repubblicani. Se fosse esclusivamente una misura dell’orientamento politico, l’unica cosa discutibile sarebbe l’etichetta, che onora un’affiliazione politica e condanna invece l’altra. La cosa però è resa più grave dal fatto che abbiamo esaltato l’apertura come una misura generale della curiosità, dell’inclinazione artistica, del perfezionamento culturale e dell’intelligenza verbale. Quindi, le persone con punteggi di apertura elevati sono più liberali, meno religiose e con un orientamento intellettuale maggiore. Come potete immaginare, questo significa che di solito non si mescolano con persone conservatrici, religiose o culturalmente poco sofisticate. E, ovviamente, il sentimento è reciproco.
Un essere umano veramente aperto, però, non finirebbe né a un estremo né all’altro, ma oscillerebbe leggermente nella fascia intermedia dei punteggi. Sarebbe, per usare il termine ormai famigerato di Cambridge Analytica, psicologicamente persuadibile, perché la sua ideologia non gli impedirebbe di cercare di connettersi con persone diverse, e non lo motiverebbe a escludere qualcuno dalla propria cerchia semplicemente in base al fatto che non è d’accordo con lui o che hanno stili di vita diversi, un retroterra diverso e così via. Questo tipo di pensiero aperto, non partigiano, agnostico rispetto ai valori, non è solo difficile da raggiungere; in realtà esistono pochi incentivi a farlo. In teoria, sembra una grande idea, logicamente fondamentale per aumentare la diversità e l’inclusione in qualsiasi gruppo o organizzazione. La realtà è che sarebbe intellettualmente molto impegnativo, ci imporrebbe di valutare tutto e tutti come una tabula rasa, perciò rinunciando alla capacità di pensare velocemente, e ci emarginerebbe dai nostri amici e dai nostri circuiti sociali. Dato che la società sta diventando più tribale, sono minori le ricompense per chi si comporta in modi non tribali.
5. Quali opportunità abbiamo per restare umani ed elevarci
L’opportunità è chiara: fare leva sull’AI per elevare anziché declassare o diluire la nostra umanità. Abbiamo una possibilità significativa di evolvere come specie, se possiamo sfruttare la rivoluzione dell’AI per rendere il lavoro più dotato di significato, sbloccare il nostro potenziale, migliorare la nostra comprensione di noi stessi e degli altri, e creare un mondo meno pieno di pregiudizi, più razionale e più dotato di senso. Ma c’è un tranello: potremo riuscire in questo intento se prima ammettiamo il rischio potenziale che l’AI amplifichi le nostre tendenze meno desiderabili, più distruttive e più controproducenti. Dobbiamo utilizzare l’AI per sbloccare o imbrigliare il nostro potenziale, anziché minare alla base o ostacolare la nostra stessa esistenza. Molto chiaramente, ci sono insegnamenti molto importanti da trarre dalla diffusione dell’AI, sul modo in cui molte dimensioni diverse della nostra umanità non vengono solo espresse ed esposte, ma anche riplasmate.
Quali espressioni importanti della nostra umanità l’AI evocherà o genererà? Alla fine, l’AI come deciderà della nostra sorte? Darà un vantaggio economico, sociale e culturale significativo alle società che sapranno dominarla? Non sappiamo come alla fine l’AI ci cambierà, ma possiamo assumere che un certo grado di cambiamento sia già avvenuto, in parte buono, in parte cattivo, e forse per la maggior parte ancora non rilevabile. Come ha osservato la scrittrice Margaret Visser,
La misura in cui diamo per scontati gli oggetti quotidiani è esattamente la misura in cui governano e informano la nostra vita.
L’umanità è un lavoro in corso, e questa può essere solo una buona cosa. L’alternativa vorrebbe dire che avremmo già raggiunto il livello più alto della nostra evoluzione. Per fortuna non siamo ancora alla vetta e ci sono chiari segni che l’umanità si sta ancora sviluppando e, sì, che sta migliorando. Non si tratta di colonizzare Marte, di costruire auto a guida autonoma, di padroneggiare l’informatica quantistica o di stampare la sposa perfetta in 4D, ma di aggiornare noi stessi: creare una versione di noi stessi più adattabile, migliorata e pronta per il futuro.
Siamo l’unica persona al mondo che possiamo sicuramente influenzare, anche se non sempre è facile. Se gli altri possono influenzarci, è perché glielo lasciaamo fare. Analogamente, se riusciamo a cambiare gli altri è solo perché in primo luogo siamo capaci di influire sul nostro stesso comportamento. Il desiderio può essere eccessivamente ottimistico e ingenuo, almeno se accettiamo il fatto storico che gli esseri umani in generale hanno avuto pochi incentivi a superare i loro predecessori sul piano del comportamento, sulla base di motivazioni evolutive, e meno che mai morali. Eppure, se creiamo le condizioni che incentivino le persone ad alzare la propria asticella, a cercare le occasioni per estendere il proprio potenziale, forse potremo vedere la civiltà umana progredire, dal basso verso l’alto, in modo organico e incrementale.
Forse in futuro ci divertiremo a sfuggire alla ragnatela delle previsioni delle macchine e troveremo momenti incantevoli di casualità, segno che la nostra creatività, la nostra ingegnosità e la nostra immaginazione sono ancora intatte. Ci troveremo magari in quei magici spazi bianchi che inventiamo e produciamo, lontani dalla portata degli algoritmi, per espandere la nostra esistenza nella capacità quasi dimenticata di sorprendere, o almeno di sorprendere noi stessi. Un’esistenza in cui deliberatamente inganneremo l’AI per sfuggire alla sintassi noiosa e ripetitiva della nostra esistenza e riscrivere la grammatica della vita in base a sentimenti, idee e azioni che rivestono scarso interesse e valore per le macchine, ma invece sono profondamente rilevanti per noi. Una vita in cui le macchine non declassano la nostra intelligenza e l’AI non ci trasforma in macchine.
Mentre la soluzione ai nostri problemi è tutt’altro che chiara, e meno che mai semplice, sicuramente dovrà incorporare una combinazione di altruismo, saggezza e ingegnosità. Come ha notato Noam Chomsky:
Siamo esseri umani, non automi. Fai il tuo mestiere, ma non per questo smetti di essere un essere umano. Essere umani significa attingere a tradizioni culturali diverse, non soltanto le nostre ma anche le altre, e acquisire così non soltanto delle competenze ma anche un sapere. Un individuo che pensa – che lo fa in modo creativo, autonomo – indaga, esplora e dà il suo contributo alla società. Se non c’è questo, si può tranquillamente essere rimpiazzati da un robot. È un elemento imprescindibile se vogliamo costruire una società in cui valga la pena vivere.
Il futuro inizia oggi. Il lavoro inizia ora.
Questo articolo richiama contenuti da Io, Umano.
Immagine di apertura di Owen Beard su Unsplash.